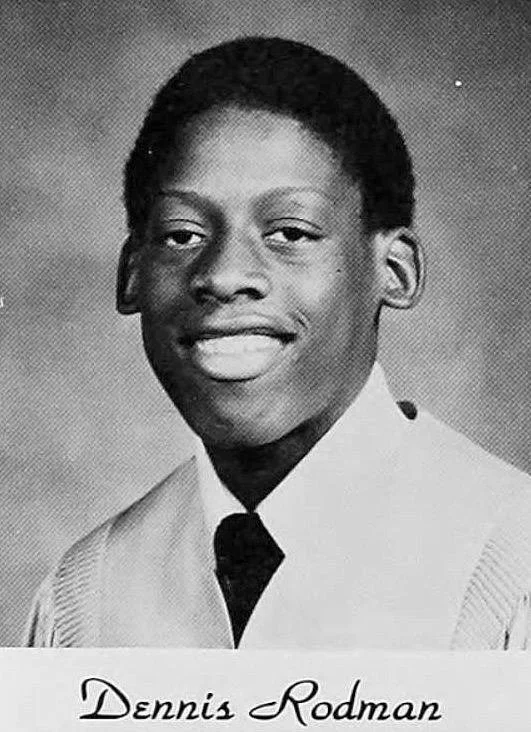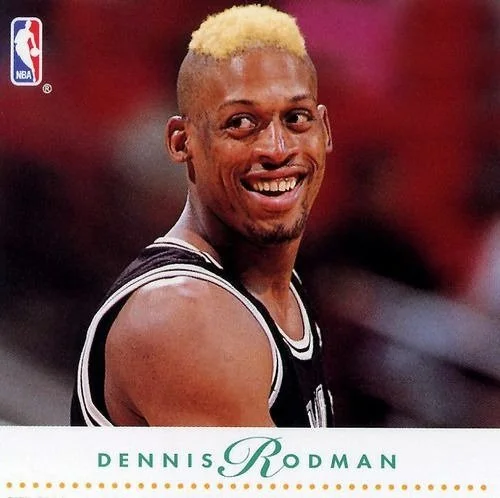Dennis Rodman, il vuoto dentro e la ricerca di un posto nel mondo
Questo articolo è per chi, almeno una volta, si è sentito fuori luogo anche dentro la propria vita.
Per chi ha passato anni a compiacere gli altri: i genitori che “ti hanno già tracciato la strada” quando avevi dieci anni, gli insegnanti che ti vedevano bene solo in certe facoltà, gli amici che si aspettavano che restassi sempre uguale a loro. È per chi ha scelto una scuola, un lavoro, una città non perché li sentiva propri, ma perché così nessuno avrebbe storto il naso.
È per chi è entrato in una relazione più per paura di restare solo che per reale desiderio, e negli anni ha continuato a recitare la parte della coppia perfetta, mentre dentro sentiva di essere cambiato in tutto: gusti, desideri, valori. Per chi continua a fingere, a dirsi “passerà”, pur di non guardare in faccia la realtà e ammettere che le strade, forse, dovrebbero separarsi.
È per chi si è svegliato un giorno, a trent’anni, a quaranta, a cinquanta, con la sensazione di aver vissuto la vita di qualcun altro: il lavoro giusto sulla carta, la relazione giusta sulla carta, la città giusta sulla carta… e quel vuoto che non va via.
Magari non hai mai avuto il coraggio di dirlo ad alta voce, ma sai benissimo cosa vuol dire vivere con l’ansia di deludere tutti, tranne te stesso.
Ci sono immagini che ti restano addosso più di qualunque frase motivazionale.
La mia, in questo periodo, è un parcheggio quasi deserto fuori da un palazzetto NBA, in una notte qualsiasi di febbraio.
Dennis Rodman è seduto da solo in macchina, nel silenzio. Non ha scarpe, non ha calzini. È un uomo che ha vinto un titolo NBA, che gioca nella lega più spettacolare del mondo, che davanti alle telecamere è già un personaggio. Ma in quella macchina non c’è “The Worm”, non ci sono i capelli colorati, non ci sono tatuaggi. C’è solo Dennis, un ragazzo cresciuto nel vuoto, con un fucile appoggiato sotto il mento, che non sa più chi è e dove sta andando.
Anni dopo dirà che, in realtà, non voleva uccidersi. Voleva uccidere l’impostore: quella versione di sé che stava vivendo una vita costruita dagli altri, non dalla sua parte più vera.
Da quando ho visto il documentario che racconta la sua storia, mi è rimasto addosso un pensiero: in fondo siamo tutti un po’ Rodman, quando per anni facciamo di tutto per essere accettati, fino a che qualcosa si spezza. Non sempre è un parcheggio con un fucile in mano. A volte è un burnout, un pianto in macchina tornando dal lavoro, una cena in cui ti accorgi che la persona seduta davanti a te non c’entra più nulla con chi sei diventato. Una sensazione costante di avere sbagliato vita.
In questo articolo ti racconto la storia di un uomo che ha faticato tutta la vita per trovare il proprio posto. E, in filigrana, è anche un pezzo della mia storia: un ragazzino di provincia chiamato “MTV boy” come insulto, che proprio da quella etichetta ha capito di non voler essere come gli altri.
Chi sono e perché ti racconto questa storia
Mi chiamo Walter Stolfi e, prima di essere un fotografo e un content creator, sono stato per anni una di quelle persone che si sentono fuori posto ovunque [ scopri di più su di me ]. Per anni, però, ho provato lo stesso a stare nei “binari”: studi “giusti”, lavori “sicuri”, tentativi di vita normale come la intendono gli altri. All’esterno sembrava tutto in ordine, dentro sentivo che stavo recitando. Finché la fotografia e il viaggio non sono diventati il mio modo concreto di ribellarmi a quella versione sbagliata di me: una macchina al collo, uno zaino, una città nuova, e la possibilità di raccontare storie di persone che, come me, hanno sempre fatto fatica a sentirsi nel posto giusto.
Strumenti che ho creato per aiutarti
Se vuoi trasformare questo sentimento in pratica quotidiana, ecco ciò che ho costruito per te (sezione breve, diretta):
Coaching 1:1 in videochiamata → ci conosciamo, scegli tu l’argomento e lo approfondiamo . [Prenota la tua sessione →]
Corso base di fotografia → fondamenta solide, meno confusione, più consapevolezza. [Scopri il corso →]
Corso di Street Photography → allena lo sguardo e racconta davvero ciò che vedi. [Scopri il corso →]
Guide fotografiche → strumenti pratici sempre con te. [Sfoglia le guide →]
Preset Lightroom → coerenza visiva e profondità alle tue foto. [Scarica i preset →]
Workshop dal vivo → esperienza di persona per approfondire meglio la fotografia [Prenota la tua sessione →]
Sentirsi sbagliati fin da bambini: il vuoto che ti porti dietro
Per capire cosa succede in quel parcheggio, bisogna tornare molto indietro.
Dennis Keith Rodman nasce nel 1961 a Trenton, nel New Jersey. Suo padre se ne va quando lui ha tre anni. Non un litigio, non una crisi passeggera: sparisce. Lascia la madre, Shirley, da sola con lui e le due sorelle più grandi. È una di quelle assenze che non hanno bisogno di essere spiegate: semplicemente, da quel momento, la figura del padre diventa un buco.
La famiglia si trasferisce a Dallas, in uno dei quartieri più poveri della città. Shirley lavora senza sosta, fa più lavori, cerca di tenere in piedi i conti e la casa. Ma il peso la indurisce. Quando sei schiacciato dalla sopravvivenza, a volte diventi duro anche con chi ami, perché non hai più energie per la dolcezza.
Dennis cresce in una casa femminile, in un quartiere ostile, con un padre assente e una madre presente nel corpo, ma spesso distratta nell’anima. È un bambino timido, introverso, che fatica a parlare, che si aggrappa alle sorelle come unica ancora. Loro lo portano in giro, lo travestono per gioco, lo includono e allo stesso tempo lo sovrastano. Sono forti, sicure, protagoniste. Lui è quello strano, quello silenzioso.
A scuola le cose non vanno meglio. Non è alto, non è atletico, non ha una personalità che domina la stanza. Diventa il bersaglio perfetto. I compagni lo prendono in giro, lo spingono, lo escludono. Lui non reagisce mai. Non si difende, non risponde, non alza la voce. Si chiude sempre di più. È quel tipo di bambino che, se lo guardi con attenzione, ti accorgi che c’è qualcosa che non va. Ma nessuno lo guarda davvero.
Prova a giocare a basket, ma viene tagliato. Prova il football, ma finisce ai margini. Non è abbastanza bravo in nulla da conquistare un ruolo. Non è il migliore per nessuno. È semplicemente “uno in più”.
In una fase così, l’identità non si costruisce; si svuota. Se per anni ti senti tolto di mezzo, messo da parte, ignorato, inizi a credere che tu, come persona, non abbia peso. Nasce un vuoto che non riguarda solo quello che fai, ma quello che sei.
Il bisogno di piacere a tutti: quando ti perdi per farti accettare
C’è un episodio che racconta perfettamente questo vuoto. Dopo il diploma, Dennis lavora all’aeroporto, facendo le pulizie. Non ha un piano, non ha prospettive, non ha nessuno che lo stia davvero guidando. È sospeso.
In uno dei negozi dell’aeroporto ruba una cinquantina di orologi. Ma non li vende. Non ne fa un giro di soldi, non li piazza al mercato nero. Li regala in giro. Li dà a persone che conosce, come fossero caramelle.
Le telecamere lo incastrano, finisce nella piccola prigione dell’aeroporto. La madre, quando lo viene a sapere, decide di lasciarlo lì una notte intera. Pensa che serva a “insegnargli una lezione”. Da un punto di vista educativo, forse è anche comprensibile. Ma da un punto di vista emotivo, quella notte è solo un altro chiodo piantato nel legno già spaccato del suo senso di sé.
Quello che mi colpisce non è tanto il furto in sé, ma il modo in cui lui lo racconta: quegli orologi non erano un modo per arricchirsi, erano un modo per provare a farsi voler bene. Una richiesta di amore travestita da gesto stupido. È come dire: “Ti do qualcosa, dimmi che valgo qualcosa”.
Quando hai passato l’infanzia a sentirti invisibile, a volte arrivi a fare qualsiasi cosa pur di essere visto. Anche sbagliata. Ma sempre con lo stesso desiderio: esistere agli occhi di qualcuno.
Shirley, a un certo punto, lo caccia di casa. Non è la prima volta, non sarà l’ultima. Dennis finisce a dormire sui divani di conoscenti, poi su una panchina, poi dietro un supermercato. Ha quasi vent’anni quando inizia a pensare che quella, probabilmente, sarà la sua vita: sopravvivere ai margini, senza un posto suo, senza una direzione.
Perdersi e poi crescere: il corpo che cambia e il basket che ti salva
Il corpo, nel frattempo, decide per lui. In poco più di un anno, Dennis passa da circa 1,75 a oltre 2 metri. È una metamorfosi silenziosa. Non c’è la musichetta da film, non c’è il montaggio con lui che schiaccia in slow motion. C’è solo un ragazzo che, all’improvviso, occupa più spazio nel mondo.
Quell’altezza, unita a un’energia grezza che non ha mai potuto usare, lo riporta al basket. Ricomincia a giocare nei campetti di provincia, poi viene notato in una palestra, poi ottiene una borsa di studio per un junior college. Non sa cosa significhi davvero “carriera”, ma capisce che la palla a spicchi potrebbe essere l’unico modo concreto per uscire dalla strada.
Alla fine approda la Southeastern Oklahoma State University, un piccolo college in una cittadina di agricoltori bianchi. È un mondo lontanissimo da quello in cui è cresciuto. Lì, per molti, un ragazzo nero di due metri è un corpo estraneo, qualcosa che genera diffidenza.
In campo, però, Dennis diventa un’altra cosa. Non perché improvvisamente si trasformi in un fenomeno tecnico, ma perché gioca come se stesse scappando da tutto il resto. Ogni rimbalzo è una fuga, ogni tuffo sul parquet è un modo per allontanarsi dalla vita che aveva prima. Non ha ancora un repertorio, non ha mosse eleganti, non ha un tiro perfetto. Ma ha una cosa che tanti non hanno: una fame feroce di non tornare indietro.
Ritrovare se stessi in una famiglia scelta: Brian e i Ricci
È in questo contesto che conosce Brian, un ragazzino bianco di tredici anni. È a un camp estivo. Brian porta addosso un dolore enorme: ha accidentalmente ucciso il suo migliore amico con un fucile. È lì perché la famiglia e il sistema cercano di raddrizzare una vita che si è piegata troppo presto.
Da fuori sembrano due opposti: un gigante nero di vent’anni, un ragazzino bianco appena adolescente. Dentro, però, hanno la stessa ferita: si sentono colpevoli di qualcosa che li ha travolti, non si sentono a casa in nessun posto.
Si riconoscono. Diventano amici. Brian invita Dennis a casa sua. Quando la madre vede comparire sulla soglia quello sconosciuto di oltre due metri, rimane scioccata. Non sa che il figlio ha portato a casa un “ventenne nero”, pensava a un coetaneo. Il primo impulso è la paura. Ma poi succede qualcosa di diverso dal solito: non lo caccia.
Con il tempo, Dennis inizia a restare. Dorme per terra nella stanza di Brian. Aiuta nei campi, munge le mucche, mangia con loro. Il padre del ragazzo lo tratta come un figlio in più. Non come un ospite, non come un intruso, non come un fenomeno da studiare. Come una persona, con un posto al tavolo.
Per la prima volta nella sua vita, Dennis sente qualcosa che non aveva mai sperimentato:
– essere voluto lì;
– non dover fare nulla di speciale per essere accettato;
– poter tornare la sera sapendo che qualcuno lo aspetta.
Arriva a chiedere ai Ricci di adottarlo. Vuole essere parte di quella famiglia, in modo ufficiale. La madre biologica si oppone. Dal suo punto di vista, è stata proprio la durezza a farlo “diventare qualcuno”. Non vede che, in realtà, quel ragazzo non aveva bisogno di un’altra lezione, ma di qualcuno che restasse nei momenti peggiori.
Quella fattoria in Oklahoma è il primo luogo in cui Dennis non si sente di troppo. Non è ancora una casa per sempre, ma è una prova che la famiglia non è solo quella in cui nasci. Può essere anche quella che ti costruisci, pezzo dopo pezzo, con chi ti sceglie e ti tiene.
Dal vuoto al successo: i Bad Boys e la seconda famiglia di Rodman
In tre anni di college, Rodman mette in mostra numeri impressionanti, soprattutto a rimbalzo. Ma più dei numeri colpisce l’energia: gioca ogni partita come se fosse l’ultima occasione per non tornare alla vita di prima.
Nel 1986, al draft NBA, viene scelto al secondo turno dai Detroit Pistons. Ha ventisei anni, un’età in cui molti sono già considerati “formati”. Lui è ancora un diamante grezzo, un corpo pieno di potenziale e un’anima piena di cicatrici.
A Detroit trova un ambiente particolare. I Pistons stanno costruendo qualcosa. C’è Isiah Thomas, playmaker straordinario, leader. C’è Bill Laimbeer, uno dei giocatori più odiati della storia, duro, provocatore, disposto a spingersi oltre i limiti. Ci sono uomini con caratteri forti, spesso detestati dal resto della lega.
Rodman entra in quel gruppo con una naturalezza strana. Da un lato è timido, quasi impacciato nelle situazioni sociali. Dall’altro, quando mette piede sul parquet, il suo corpo sa esattamente cosa fare: difendere, lottare, tuffarsi. Non chiede palloni, non reclama tiri. Fa tutto quello che gli altri non vogliono fare.
Il coach Chuck Daly capisce che c’è qualcosa di fragile lì dentro. Lo tratta con un’attenzione speciale, diventa una sorta di padre non dichiarato. Lo invita a casa per le feste, lo protegge, gli dà la sensazione di essere visto anche oltre il giocatore.
In quei Pistons, che il mondo conoscerà come i “Bad Boys”, Dennis trova una seconda famiglia. Il palazzetto è un’arena, ma lo spogliatoio è un rifugio. Lì non è il bambino bullizzato, non è il figlio cacciato di casa, non è il ragazzo che dormiva per strada. È un pezzo fondamentale di un gruppo che sta provando a vincere contro tutti, anche contro la narrativa che li vorrebbe sempre e solo “cattivi”.
Con il tempo arrivano i successi: due titoli NBA, il premio come difensore dell’anno, l’amore dei tifosi. C’è un momento, quando ritira il premio di miglior difensore, in cui si mette a piangere a dirotto. Non sono lacrime di gioia superficiale. Sono anni di invisibilità che si sciolgono all’improvviso, di fronte a una sala piena che finalmente lo riconosce come uno dei migliori.
Ma, ancora una volta, il successo non basta a curare le ferite più profonde.
Se non fai pace con la tua storia, il vuoto rimane lì, anche se ti appendi una medaglia al collo.
Il parcheggio col fucile: il momento in cui inizi a ritrovare te stesso
La NBA è un sistema che costruisce e distrugge cicli. I Bad Boys non fanno eccezione. Dopo aver vinto, iniziano a perdere pezzi. Le sconfitte con i Chicago Bulls di Jordan segnano la fine di un’epoca. Giocatori chiave vengono scambiati, il gruppo si sfilaccia, Chuck Daly se ne va.
Per il mondo è una naturale evoluzione sportiva. Per Dennis è un lutto. Un’altra famiglia che si smonta davanti ai suoi occhi, un’altra figura paterna che si allontana, un’altra struttura che lo teneva in piedi e che viene meno.
In questo clima, nella notte dell’11 febbraio 1993, fuori dal palazzetto dei Pistons, Dennis si siede in macchina con un fucile. È scalzo, è solo, è stanco. Ha già vinto, ha già dimostrato, ha già conquistato. Eppure dentro è tornato quel bambino convinto di non valere niente senza qualcuno che lo tenga.
Non sappiamo cosa sia davvero passato nella sua testa in quelle ore. Sappiamo che non ha premuto il grilletto. Si è addormentato. Lo hanno trovato il mattino dopo, ancora lì. Da fuori, è facile leggere la scena come l’ennesimo eccesso di un personaggio sopra le righe. Da dentro, è un punto di rottura.
Anni dopo, quando racconta quell’episodio, dice che non voleva togliersi la vita. Voleva eliminare l’impostore. Quella versione di sé che aveva vissuto per anni cercando di piacere: alla madre, agli allenatori, ai compagni, al pubblico, ai media. Voleva liberarsi del ruolo di bravo soldato, di pezzo del sistema, e dare una forma esterna a quello che sentiva di essere davvero.
Il parcheggio col fucile è il suo “basta”. Da lì in poi, tutto quello che vedremo – capelli colorati, tatuaggi, piercing, abiti assurdi – non sono la maschera. Sono, nel bene e nel male, la vera faccia.
Capelli biondi, tatuaggi e libertà: decidere di essere se stessi
Dopo quella crisi, Rodman viene scambiato ai San Antonio Spurs. Passa da una squadra costruita sulla fisicità e sul conflitto a una franchigia ordinata, disciplinata, quasi militare. Ma dentro di lui la diga è già crollata.
Il giorno della presentazione con gli Spurs, arriva in ritardo. Entra con un cappellino in testa, prende il microfono, si mette davanti ai tifosi e dice una frase che è un manifesto:
“Potete amarmi o potete odiarmi, ma so una cosa:
quando metto piede in campo do tutto me stesso.”
Poi si toglie il cappello. I capelli sono biondo platino, ispirati a Wesley Snipes in “Demolition Man”. È un primo segno. In realtà, da lì in poi, ogni suo cambiamento estetico sarà un messaggio. Colori, disegni, piercing, tatuaggi: un modo per dire al mondo “io sono questo qui, prendere o lasciare”.
Il problema è che il mondo dello sport non è pronto per un personaggio del genere. La NBA sta provando a costruire un’immagine pulita, rassicurante, adatta agli sponsor. Rodman non entra in nessun manuale di comunicazione. Frequenta locali gay, si dichiara etero ma racconta fantasia omosessuali, si presenta in abiti da sposa, esce con Madonna, posa su copertine che sfidano apertamente l’idea di mascolinità dominante in quegli anni.
Tutto questo farebbe già abbastanza scalpore se fosse un mediocre. Ma il punto è un altro: in campo continua a essere uno dei giocatori più efficaci della lega. Vince per anni di fila la classifica rimbalzi, difende chiunque, si sacrifica come pochi. È caos fuori, ordine perfetto dentro il perimetro del parquet.
A San Antonio, però, l’esperimento esplode. Troppo grande il contrasto tra la sua voglia di libertà assoluta e la cultura della franchigia. L’energia che prima era incanalata in un contesto che la reggeva, ora diventa ingestibile. Litigi con lo staff, squalifiche, espulsioni. È come se tutto quello che aveva tenuto dentro per vent’anni stesse uscendo tutto insieme.
Chicago, Jordan e il valore di chi fa il lavoro “sporco”
Quando gli Spurs non ne possono più, sembra che la carriera di Rodman sia arrivata a un bivio. È troppo forte per essere ignorato, ma troppo imprevedibile per essere accettato facilmente. In quel momento, entrano in scena i Chicago Bulls di Michael Jordan.
Il coach Phil Jackson e lo staff sanno che per tornare a vincere hanno bisogno di fisicità, di rimbalzi, di qualcuno che faccia il lavoro sporco accanto a Jordan e Pippen. Il nome di Rodman è in fondo a una lista. È l’opzione più rischiosa, quella che nessuno, razionalmente, scelgerebbe per prima. Ma è anche quella che può spostare davvero gli equilibri.
La storia dice che alla fine lo prendono. Prima di firmare, Jackson lo porta da Jordan e Pippen per capire se sono disposti a giocare con un uomo che, fino a pochi anni prima, li picchiava letteralmente in campo quando vestiva la maglia dei Pistons. Scottie Pippen ha ancora addosso la memoria fisica di quei colpi. Michael è più freddo: riconosce il valore tecnico, capisce che per vincere bisogna saper convivere con il caos.
Rodman arriva a Chicago con i capelli già colorati, le storie già pubblicate, la fama già costruita. Non prova neanche a sembrare “normale”. Ma quando la palla va in aria, diventa il collante perfetto.
Non segna. Non chiede palloni. A volte gioca partite intere in cui mette a referto due punti e venti rimbalzi. È un ruolo che non fa copertina, ma che toglie peso dagli altri. Ogni rimbalzo in più che prende è un tiro in più che Jordan e Pippen possono prendere senza preoccuparsi di recuperare la palla.
In una lega costruita sul culto dell’eroe che mette il tiro allo scadere, Dennis costruisce una carriera sulla scelta opposta: essere il numero uno in un lavoro invisibile. Farsi carico della fatica, del contatto, del dolore. È come se avesse deciso di trasformare l’abitudine al colpo, al giudizio, al rifiuto in un superpotere al servizio della squadra.
I Bulls vincono. Vincono tanto. Vincono ancora. E gran parte di quel dominio passa da un uomo che, nella narrazione facile, viene ricordato solo per i capelli e per i piercing. In realtà, sotto la superficie, c’è uno dei giocatori più intelligenti e più consapevoli del proprio ruolo che la NBA abbia mai visto.
Il me stesso di provincia che si sentiva fuori posto
Mentre guardavo tutto questo, la mia testa andava a un posto molto diverso da Detroit o Chicago: il mio paesino di provincia.
Non è America, non è NBA, non ci sono palazzetti pieni. Ci sono strade sempre uguali, bar dove gli argomenti sono sempre gli stessi, scuole in cui l’orizzonte sembra finire al cancello. È l’Italia di provincia, quella dove basta pochissimo per essere considerato “strano”.
Alle scuole medie ho iniziato a vestirmi in un modo che, per i miei standard di allora, era rivoluzionario: pantaloni larghi, magliette ispirate all’hip hop, un orecchino al lobo sinistro, qualche dettaglio rubato ai video che guardavo su MTV. Passavo ore davanti al canale, appena potevo. Assorbivo i suoni, i colori, i movimenti. Mi affascinavano i rapper americani, le band, le culture che non somigliavano per niente al mondo che vedevo fuori dalla finestra.
Il cortocircuito era inevitabile. Entravo in classe con quei pantaloni e sentivo gli sguardi. Non erano sguardi curiosi. Erano sguardi che dicevano “perché non ti vesti come gli altri?”. Alcuni lo trasformavano in parole: battutine, risatine, prese in giro. Ancora tutt’oggi, in alcune situazioni, lo scenario si ripresenta.
C’era chi mi chiamava “MTV boy” come se fosse un insulto.
Era il modo per dirmi che ero fuori posto, che non c’entravo niente con il contesto, che stavo recitando un ruolo che non mi apparteneva.
La cosa strana è che, invece di farmi sentire in colpa o piccolo, quella etichetta mi dava quasi sollievo. In qualche modo mi confermava che stavo andando in un’altra direzione. Nessuno dei miei amici ascoltava la mia musica, nessuno si vestiva come me, nessuno condivideva le stesse fissazioni. Addirittura una volta, scesi dal treno al ritorno da scuola, un ragazzo mi guarda e mi dice:
”Togliti subito quella maglia, non puoi vestirti così”.
Mi sentivo solo, sì, ma non volevo tornare indietro.
Certo, anche io ho avuto i miei tentativi di “normalizzazione”. Ci sono stati periodi in cui ho provato a rientrare nei canoni, a scegliere strade più tranquille, a fare il percorso che ci si aspettava. Studi, lavori “seri”, scelte apparentemente logiche.
Ma sotto la superficie il “MTV boy” non è mai sparito. Quella parte di me che guardava altrove, che si immaginava in altre città, che si nutriva di immagini, di musica, di storie, continuava a bussare.
Quando ho iniziato a viaggiare, a fotografare, a raccontare ciò che vedevo, ho semplicemente dato una forma concreta a quella voce. La macchina fotografica è diventata il mio modo di stare al mondo. Non come turista, ma come osservatore. Non come spettatore passivo, ma come qualcuno che prova a trasformare le proprie ossessioni in qualcosa di condivisibile.
Non sono Jordan, non lo sarò mai. Non ho mai avuto il talento di essere il “numero uno” in qualcosa nel senso classico del termine. Ma, piano piano, ho iniziato a capire che il mio compito non era quello. Il mio compito era trovare il mio rimbalzo: il ruolo in cui la mia stranezza potesse smettere di essere un peso e diventare utile a qualcuno.
Il tuo rimbalzo: da dove puoi ricominciare a ritrovare te stesso
La storia di Rodman non è una favola con il lieto fine perfetto. Dopo i Bulls, dopo i titoli, la sua vita continua a essere piena di cadute, errori, scelte discutibili, dipendenze, rapporti complicati. Non diventa mai l’eroe pulito che ti aspetteresti in un film.
E forse è proprio questo che la rende così potente. Perché non ci racconta che basta “credere in sé stessi” e tutto va a posto. Ci mostra piuttosto quanto sia difficile, anche quando ce l’hai fatta, restare a galla se non fai pace con quello che sei.
Eppure, in mezzo a tutte le contraddizioni, una cosa rimane: quel ragazzo che da piccolo si sentiva di troppo, non abbastanza, invisibile, è riuscito a trasformare il proprio vuoto in un ruolo unico. Ha trovato un posto nel mondo in cui niente di quello che aveva vissuto era sprecato: la durezza, la solitudine, il bisogno di essere visto, la capacità di reggere il colpo. Tutto è finito nel modo in cui andava a rimbalzo, difendeva, lottava.
Quando penso a lui e penso a me – al ragazzino con i pantaloni larghi e l’orecchino nel paesino dove tutti dovevano essere uguali – mi viene da farti una sola domanda, molto semplice e molto difficile:
qual è il tuo rimbalzo?
Non necessariamente quella cosa epica per cui verrai ricordato nei libri di storia. Magari è un talento minuscolo, che non fa rumore. Magari è il modo in cui sai ascoltare, in cui sai vedere dettagli che gli altri ignorano, in cui sai raccontare, in cui sai organizzare, in cui sai creare connessioni.
Forse da bambino ti hanno fatto sentire sbagliato proprio per quella cosa lì. Forse ti hanno detto che era inutile, che non serviva a niente, che dovevi diventare “altro”. Forse, oggi, ti porti ancora addosso quell’impressione di recitare, di interpretare un ruolo che non ti appartiene del tutto.
Non ti dirò che devi mollare tutto domani mattina. Non ti dirò che devi tingerti i capelli di verde e lanciare un urlo liberatorio dal balcone. Ma credo che, ad un certo punto, tutti arriviamo a un nostro parcheggio.
Non sempre c’è un fucile. A volte c’è solo un silenzio. Una sera in cui ti guardi allo specchio e pensi: “Così non va più bene”.
Quello è il momento in cui puoi scegliere se continuare a far vivere l’impostore, o iniziare – lentamente, imperfettamente – a lasciare spazio a quello che sei davvero.
Rodman, in quella macchina, ha scelto di uccidere l’impostore.
Io, nel mio piccolo, ogni giorno cerco di scegliere il “il vero me” che guarda altrove, invece della versione di me che sarebbe stata più facile da accettare.
Tu, oggi, non devi rispondere a me. Devi solo iniziare a rispondere a te stesso.
Continua a leggere
Se sei interessato a migliorare le tue abilità fotografiche, ti invito a dare un'occhiata alle risorse disponibili sul mio sito, come:
Corsi: Segui i miei Corsi di Fotografia partendo dalle basi fino alla Street Photography.
Guide Fotografiche: Per scegliere la giusta Fotocamera e Per raccontare storie con la Fotografia.
Preset di Lightroom: Ottimizzati per qualsiasi tipo di Fotocamera e Smartphone
Coaching online: Sessioni 1:1 Personalizzate in base al tuo stile e ai tuoi obiettivi.
Workshop: Un’esperienza dal vivo immersiva tra tecnica, racconto e condivisione.
Continua a seguire le mie avventure fotografiche e i racconti di viaggio sul BLOG, e non dimenticare di iscriverti al mio canale YouTube per supportare il mio lavoro e rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. Insieme, possiamo scoprire il mondo, una fotografia alla volta.